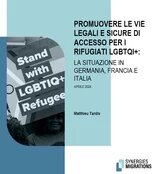Trent'anni fa, il termine “Fortezza Europa” era ancora un'immagine e nessuno immaginava che un giorno si sarebbe tradotto in oltre 2.000 chilometri di frontiere esterne “protette” da muri, recinzioni e fossati. Eppure, ogni fortezza può aprire i suoi ponti levatoi. Perché alcune persone sono esenti dal visto, mentre altre non hanno altra scelta che intraprendere un percorso migratorio pericoloso e incerto? Il sistema dei “ponti” che consentono l'accesso all'UE dovrebbe essere meglio identificato e inquadrato dalla politica migratoria degli Stati membri dell'UE.

-
Frontiere chiuse e fossati aperti
Il termine “Fortezza Europa” nasce nei primi anni ’90 in riferimento alle politiche restrittive degli stati europei in materia di asilo e immigrazione e, più nello specifico, al combinato disposto delle politiche restrittive in materia di visti, dell’inasprirsi dei controlli alle frontiere e delle sanzioni ai vettori che non effettuavano adeguati controlli dei documenti dei loro passeggeri.
Attualmente, sono 102 i paesi le cui cittadine e i cui cittadini necessitano di un visto d’ingresso nell’Unione Europea. L’obbligo di visto riguarda l’intero continente africano, tutti i paesi del Medio Oriente (eccezion fatta per Israele), nonché l’Asia centrale e molti stati dell’Estremo Oriente e dell’America Latina. Tra le ragioni per l’ottenimento del visto non figurano né “asilo” né “protezione internazionale”, anzi: tra i compiti dei consolati degli stati membri c’è proprio quello di verificare che non vi sia il “rischio” che chi sta richiedendo il visto presenti domanda d’asilo una volta varcata la frontiera o che una richiesta di visto per “motivi familiari” celi l’intenzione di intraprendere un’attività lavorativa.
Trent’anni fa, quella della “Fortezza Europa” era soltanto una metafora: nessuno immaginava che potesse concretizzarsi nei muri, nelle recinzioni e nei fossati che oggi “proteggono” la frontiera esterna dell’UE per oltre 2.000 chilometri, ossia per il 15% circa dei suoi confini terrestri. Nel 2014 i chilometri “protetti” erano solo 315.[1]
Inoltre, l’UE e i singoli stati membri hanno siglato accordi con quasi tutti i paesi nordafricani e mediorientali affacciati sul Mediterraneo, investendo miliardi di euro per contrastare le partenze irregolari.[2]
Insomma: ad oggi la fortezza è in piedi e diventerà sempre più estesa. Invertire o persino contenere questa tendenza sembra piuttosto irrealistico. Eppure, ogni fortezza può aprire i suoi ponti levatoi. Ecco, allora, che l’Unione Europea deve porsi quella che con tutta probabilità è la domanda più urgente sulla sua politica migratoria: come devono essere questi ponti? Come devono funzionare? E a chi dev’essere consentito percorrerli per raggiungere l’Europa in modo legale e sicuro?
-
L’esenzione dal visto – modello Ucraina e modello Venezuela
Gli stati sono alle prese con un vero e proprio dilemma: da un lato voler facilitare l’ingresso al proprio territorio per i vantaggi economici e politici che questo comporta e dall’altro, dover limitare la mobilità e inasprire i controlli per motivi di politica demografica e di sicurezza. Perciò tendono a privilegiare cittadine e cittadini provenienti da specifici paesi, agevolandone attivamente l’ingresso per ragioni di lavoro, come avveniva negli anni ’50 e ’60 con i cosiddetti “lavoratori ospiti” e attualmente per la forza lavoro altamente specializzata. Al contempo, vietano o rendono difficoltoso l’ingresso da alcuni paesi, generalmente quelli più poveri, e a certi richiedenti asilo e migranti “indesiderati”. Da una ricerca di Eric Neumayer, che non si limitava alla sola Unione Europea, è emerso che più un Paese è povero, democraticamente debole ed esposto a conflitti militari attuali o potenziali, più è soggetto a un regime restrittivo in materia di visti. Per contro, l’accesso al territorio di uno stato si fa tendenzialmente più semplice per chi proviene da un paese che ha con esso rapporti commerciali e affinità culturali o dal quale ci si aspetta un notevole afflusso di turisti.[3]
Queste regole, però, presentano le loro eccezioni: Venezuela e Ucraina, per esempio, godono di un regime di esenzione dal visto (rispettivamente dal 2016 e dal 2017). Negli ultimi anni, entrambi sono tra i principali paesi di provenienza delle persone rifugiate in Europa.
Esenti dall’obbligo di visto, entro 90 giorni dall’ingresso nell’area Schengen, le cittadine e i cittadini di Venezuela e Ucraina possono presentare domanda di protezione internazionale in un paese UE a loro scelta. Essendo entrati legalmente sul territorio dell’Unione Europea, infatti, non sono soggetti al regolamento di Dublino in merito alla competenza dello stato membro di primo ingresso.
Secondo Daniel Thym si tratterebbe di una stupefacente reintroduzione di fatto del “modello free choice” per richiedenti asilo.[4] Le ucraine e gli ucraini rifugiatisi in Europa sono 4,4 milioni: un numero decisamente superiore a quello delle richieste d’asilo presentate durante la “crisi dei rifugiati” del 2015 (1,3 milioni). Eppure, non si è certo registrata un’analoga indignazione da parte della politica e dell’opinione pubblica.
Allargare il regime di esenzione a un maggior numero di paesi, ovvero sollevare le loro cittadine e i loro cittadini dall’obbligo di visto per accedere al territorio europeo, significherebbe contribuire a una notevole distensione per quanto concerne la questione della migrazione e dell’asilo. In particolare, significherebbe
- ridurre il numero delle vittime nel Mediterraneo e lungo altre rotte migratorie;
- portare a un sostanziale superamento del sistema di Dublino;
- sottrarre almeno una parte di “mercato” ai trafficanti di esseri umani;
- disinnescare il dibattito sull’immigrazione clandestina;
- rivalutare il principio di legalità nell’ambito delle politiche migratorie.
Per contrastare il timore che l’esenzione dal visto porti a una vera e propria “invasione” di migranti e richiedenti asilo basta considerare alcuni dati. Secondo l’UNHCR, a livello globale la maggior parte della popolazione rifugiata vive nei paesi limitrofi a quelli di provenienza (67%)[5], non avendo né il desiderio né i mezzi per proseguire il proprio viaggio. Emblematico è il caso del Venezuela, da dove negli ultimi anni ben 6 milioni di persone si sono rifugiate nei vicini Colombia, Perù, Brasile ed Equador, mentre il numero di coloro che hanno presentato domanda d’asilo nell’Unione Europea si è mantenuto piuttosto basso nonostante l’esenzione dall’obbligo di visto: nel 2024 si è trattato soltanto di 73.000 domande d’asilo (l’8% del totale), anche se, nei primi mesi del 2025, si è registrato un aumento.[6] Di questi richiedenti, la stragrande maggioranza si è fermata in Spagna, il paese europeo più vicino per lingua e cultura, e non si è avvalsa della possibilità di stabilirsi legalmente in altri stati membri. Va poi sottolineato che la maggioranza della popolazione siriana fuggita dopo lo scoppio della guerra civile nel 2011 è rimasta per molti anni nei paesi limitrofi Turchia, Libano e Giordania, spostandosi in Europa occidentale solo dopo il drastico taglio degli aiuti internazionali nei suddetti paesi. Insomma, per l’Unione Europea sembrerebbe proprio arrivato il momento di prendere seriamente in considerazione un graduale superamento dell’obbligo di visto.
-
Resettlement – una nuova cornice per un vecchio quadro?
L’UNHCR definisce resettlement (reinsediamento) il trasferimento volontario, sicuro e regolamentato di rifugiate e rifugiati da un paese in cui hanno cercato protezione a un altro stato che accetta di accoglierli come rifugiati con status di soggiornanti permanenti. Si tratta di una soluzione di lungo periodo pensata principalmente per gli elementi più vulnerabili della popolazione rifugiata, la cui vita, la cui libertà, la cui sicurezza e i cui diritti fondamentali risultino a rischio nel paese di prima accoglienza. Già negli statuti dell’UNHCR del 1950, l’istituto del reinsediamento figura quale terza soluzione durevole al problema della popolazione rifugiata, al quale ricorrere qualora non siano applicabili le prime due opzioni, ovvero il rimpatrio volontario e l’integrazione nel paese d’asilo. Tradizionalmente, i paesi di reinsediamento sono stati USA, Canada, Australia e, per quanto riguarda l’Europa, coinvolta in misura decisamente minore, soltanto i Paesi scandinavi.
Fino al 2015 i posti disponibili per il reinsediamento interno all’Unione Europea erano meno di 5.000 all’anno. Con la “crisi dei rifugiati” e l’accordo UE-Turchia del 2016, c’è stato però un costante aumento, fino ad arrivare a 27.000 posti nel 2019, seguito poi da un calo che li ha riportati a una quota annua di circa 14.000 nel 2023 e nel 2025, di cui il 60% in due soli paesi, Germania e Francia. Tra le prime misure adottate dal nuovo governo USA c’è proprio il taglio radicale del programma statunitense di resettlement, che era stato notevolmente ampliato sotto l’amministrazione Biden. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, teme che, dopo il picco di 190.000 posti del 2024, nel 2025 il numero globale dei posti destinati al reinsediamento possa subire il maggior calo degli ultimi 20 anni – e questo a fronte di un fabbisogno stimato di 2,5 milioni.
Nel maggio del 2024, l’UE ha adottato un regolamento sul quadro per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria nell’ambito del “nuovo patto” su asilo e migrazione.[7] Nel corso del dibattito su questo nuovo patto, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha ripetutamente sottolineato l’importanza dei “canali d’accesso complementari” per consentire a migranti e persone rifugiate l’ingresso sul territorio europeo. Per l’UE, infatti, la funzione principale del reinsediamento e dell’ammissione umanitaria dev’essere proprio quella di dar vita a un canale d’immigrazione regolare.
Secondo il regolamento quadro, gli stati membri procederanno al reinsediamento su base volontaria: benché vengano fissati obiettivi quantitativi nell’ambito di un programma biennale, nessuno sarà obbligato a parteciparvi. Quantomeno, però, l’Unione Europea metterà sul piatto degli incentivi economici: per ogni persona accolta su base volontaria, agli stati membri spetterà un contributo di 10.000 euro. Chi verrà selezionato (direttamente dall’UNHCR o in collaborazione con esso) per partecipare al programma potrà entrare legalmente nello stato membro che ha messo a disposizione il posto, otterrà “automaticamente” un permesso di soggiorno permanente (senza, cioè, dover ripercorrere la procedura d’asilo) e avrà diritto al ricongiungimento familiare. Nei paesi di prima accoglienza, le selezioni dovranno dare priorità alle persone particolarmente vulnerabili senza tenere in considerazione le maggiori o minori possibilità di integrarsi nel paese d’arrivo.
È fuori discussione che il reinsediamento sia un meccanismo fondamentale per garantire l’accesso sicuro e l’accoglienza della popolazione rifugiata. Negli ultimi dieci anni, questo meccanismo ha conosciuto un notevole sviluppo nell’UE e adesso è stato finalmente inquadrato dal punto di vista giuridico. C’è, però, il limite dei numeri: finché riguarderà all’incirca il 2-3% di tutti i richiedenti asilo che decidono di recarsi in Europa, questo “ponte” rimarrà troppo stretto per costituire una vera e propria alternativa agli arrivi irregolari.
Ammissione umanitaria – la società civile apre la strada
In Italia, nel 2016, alcune organizzazioni non governative legate alla Chiesa cattolica e a quella valdese hanno dato vita al progetto dei “corridoi umanitari”, consentendo a un certo numero di persone rifugiatesi in paesi mediorientali e africani di entrare legalmente in Italia. Per farlo hanno siglato un accordo con i Ministeri degli Esteri e dell’Interno, impegnandosi a garantire la copertura dei costi di viaggio, accoglienza e integrazione con fondi esclusivamente privati. Lo stato italiano, invece, ha provveduto al nulla osta di sicurezza e al rilascio dei visti presso i rispettivi consolati italiani.
“In casi straordinari”, infatti, il Codice dei Visti Schengen consente il rilascio di visti umanitari: a differenza degli ordinari visti Schengen, i visti umanitari sono validi esclusivamente per il paese che li rilascia e non consentono di proseguire il viaggio verso altri paesi dell’UE.
Accolto positivamente da media e opinione pubblica, il modello dei corridoi umanitari è stato sperimentato anche in Francia e Belgio. In totale, questi progetti hanno portato all’accoglienza di 8.400 persone, di cui la maggior parte in Italia, dove nel 2025 sono state accolte anche persone rifugiate provenienti dall’Afghanistan e da Gaza. I “corridoi umanitari” potrebbero aprire la strada a iniziative di accoglienza realizzate attraverso la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private e meriterebbero di essere considerevolmente ampliati, sia in termini di stati membri coinvolti sia per numero di posti messi a disposizione.
-
Community sponsorship: un modello importato dal Canada
L’idea è semplice: oltre a stabilire quote per il resettlement o l’ammissione umanitaria, lo Stato dovrebbe consentire anche l’ingresso di persone rifugiate sponsorizzate da comunità della società civile. Può trattarsi di qualsiasi tipo di “comunità”: organizzazioni di quartiere, comunità religiose e, in alcuni casi, anche parenti già residenti nel paese. Per solidarietà e considerazioni umanitarie, queste comunità decidono di assumersi per un certo lasso di tempo i costi dell’accoglienza e di accompagnare e sostenere le persone accolte nel loro percorso di integrazione.
I corridoi umanitari fanno parte delle cosiddette “community sponsorship”, le sponsorizzazioni comunitarie, nate e sperimentate molti anni fa in Canada e successivamente sviluppate in varie forme anche in Australia, in Nuova Zelanda e in alcuni paesi dell’America Latina.[8] Non si tratta semplicemente di dare ad un certo numero di persone la possibilità di entrare legalmente in un dato paese, ma anche di agire in maniera strategica per spingere gli stati ad impegnarsi di più nella creazione di vie d’accesso legali.
-
Richieste d’asilo presso le ambasciate
Già vent’anni fa, la Commissione Europea aveva commissionato uno studio approfondito di fattibilità delle procedure consolari, le cosiddette Protected Entry Procedures (PEP). Benché preso in considerazione nel dibattito politico, soprattutto nell’ambito del Parlamento Europeo, lo studio realizzato da Gregor Noll[9] non è stato menzionato in nessuna comunicazione successiva della Commissione né, tanto meno, in uno dei suoi programmi quinquennali. Le PEP avrebbero consentito di presentare domanda d’asilo presso una rappresentanza diplomatica del paese dove si ambiva ad essere accolti. Dopo un colloquio con la o il richiedente (a oggi effettuabile online dalle autorità nazionali competenti in materia di asilo) e un sommario esame preliminare della domanda, in caso di esito positivo, la rappresentanza diplomatica avrebbe rilasciato un visto d’ingresso per consentire lo svolgimento della procedura di asilo vera e propria nel paese scelto dalla o dal richiedente.
In caso di diniego, invece, si sarebbe dovuta prevedere la possibilità di ricorso presso il tribunale competente. Alcuni paesi, come Svizzera e Spagna, hanno effettivamente introdotto e testato la procedura consolare, ma l’hanno poi sospesa, principalmente perché la ritenevano un modello da adottare a livello europeo e non soltanto nazionale. Va sottolineato che, comunque, nell’agosto 2025 un tribunale romano ha ordinato all’ambasciata italiana di Tel Aviv di rilasciare un visto umanitario a una famiglia di Gaza.[10] Anche il dibattito sulle procedure consolari, che a differenza del reinsediamento e dell’ammissione umanitaria non prevedono quote fisse, andrebbe rilanciato e integrato nella strategia europea.
-
Ricongiungimento familiare allargato
Da una serie di ricerche è emerso che molte persone rifugiate e migranti entrano irregolarmente nell’UE per raggiungere familiari già presenti sul territorio e non per richiedere la protezione internazionale o per motivi di lavoro. La direttiva europea sul ricongiungimento familiare fa riferimento a un concetto di famiglia ristretto e lontano dalla realtà di molti dei paesi d’origine delle persone interessate: salvo poche eccezioni, infatti, la famiglia include soltanto coniugi e figli e figlie minori non sposati. Inoltre il ricongiungimento prevede procedure complesse e richiede documenti spesso impossibili da ottenere, soprattutto per chi è fuggito dal proprio paese. Se si ha, per esempio, un fratello o una sorella da tempo residenti in Europa non c’è possibilità di entrare legalmente. Per ridurre il numero degli ingressi irregolari si potrebbe ampliare la definizione di famiglia, semplificare le procedure e dedicare sufficiente personale al rapido vaglio della situazione socio-economica che attende la o il richiedente nel paese d’arrivo, per garantire che, in seguito al ricongiungimento, la famiglia non si ritrovi a dipendere dalle misure di welfare. Qui potrebbe rientrare in gioco il modello sponsorship, con la differenza che in questo caso a coprire i costi non sarebbero le comunità, ma appunto la famiglia residente.
Non solo “lavoratori ospiti”: serve una nuova politica migratoria
Al complesso tema della migrazione economica non possiamo in questa sede dedicare che alcuni rapidi cenni. Di pari passo con l’inasprirsi delle politiche migratorie crescono le domande d’asilo presentate da coloro che vorrebbero ottenere un permesso di soggiorno: oggi più che mai, questa correlazione è una certezza. Considerata la diffusa carenza di forza lavoro in Europa, anche chi entra irregolarmente oppure rimane sul territorio dopo la scadenza del visto ha buone possibilità di trovare un lavoro. Con le nascite in calo e una popolazione che invecchia, è più che probabile che questa tendenza si mantenga anche a prescindere dalle congiunture economiche. Limitare l’ingresso legale alla forza lavoro altamente qualificata significa non soddisfare le esigenze reali del mercato del lavoro. Nei primi anni duemila, l’Italia aveva introdotto – purtroppo solo brevemente – la possibilità di rilasciare visti temporanei per la ricerca di lavoro; una possibilità che andrebbe ripresa in considerazione soprattutto alla luce del fatto che nel lavoro di cura, settore in crescita, è necessario il contatto diretto tra datore di lavoro e lavoratore, e dunque la presenza fisica della o del migrante sul territorio. Anche in questo caso la sponsorizzazione temporanea, per esempio da parte delle associazioni datoriali o dei sindacati, potrebbe ridurre il rischio per la sostenibilità del welfare.
-
Gli ingressi legali avvantaggiano tutti
Con l’eccezione delle esenzioni dall’obbligo di visto per alcuni paesi, tutti i “ponti” qui descritti hanno diversi vantaggi per gli stati che li adottano:
■ consentono di verificare prima dell’ingresso sul territorio che le persone migranti e rifugiate non presentino rischi per salute e sicurezza;
■ consentono alle autorità competenti del paese d’accoglienza di conoscerne i dati personali prima dell‘ingresso sul proprio territorio;
■ consentono di stabilire prima dell’ingresso lo stato membro competente;
■ rendono superfluo l’espletamento delle procedure d’asilo alla frontiera esterna e la privazione della libertà che queste comportano, in base alla nuova direttiva sulla procedura d’asilo;
■ consentono di conoscere e pianificare prima dell‘ingresso sul proprio territorio l’afflusso migratorio per richiesta di asilo, lavoro o ricongiungimento familiare;
■ consentono di pianificare nei tempi e nei numeri l’accoglienza delle rifugiate e dei rifugiati.
Il miglioramento della gestione di asilo e migrazione a cui mira il “Nuovo patto”[11] si potrà ottenere soltanto ampliando i canali d’accesso legali in modo che, complessivamente, possano rappresentare un’alternativa concreta all’immigrazione irregolare.
Traduzione di Susanna Karasz, edizione di Isabel Cellati | Voxeurop
[1] Parlamento Europeo, Briefing, Walls and Fences at EU-Borders, EPRS Bri(2022)733692_EN.pdf
[2] Per un elenco e un‘analisi di tali accordi cfr. C. Hein, Maginot Line Around Europe? Assessing the Impact of EU- Agreements with MENA countries on Migration Flows to Europe, 2025, https://mp.luiss.it/archives/maginot-line-around-europeassessing-the-im…
[3] E. Niemayer, Unequal access to foreign spaces: how States use visa restrictions to regulate mobility in a globalized world; London School of Economics, Research online, 2006
[4] D. Thym, Temporary Protection for Ukrainians: the Unexpected Renaissance of „Free Choice“, in: EU Immigration and Asylum Policy, 7 March 2022, https://eumigrationlawblog.eu/temporary-protection-for-ukrainians-the-u…
[5] https://www.unhcr.org/global-trends. I dati fanno riferimento a fine 2024.
[6] Visto il forte calo del numero delle e dei richiedenti siriani, nel primo semestre del 2025 venezuelane e venezuelani sono stati il principale gruppo di richiedenti asilo. Tutti i dati sono tratti da: https://euaa.europa.eu/latest-asylum-trends
[7] Regolamento UE 2024/1350 del 14 maggio 2024
[8] È prevista per fine 2025 l’uscita di un’ampia pubblicazione dell’Università di Viterbo in collaborazione con ricercatori di vari paesi, intitolata „Towards a European Model of Community Sponsorship for Migrants and Refugees: The Legal Perspective“. Lo studio prende in esame singole esperienze fatte a livello internazionale nella prospettiva di una loro possibile applicazione negli stati membri dell’Unione Europea.
[9] Per una sintesi cfr. https://www.refworld.org/reference/research/unhcr/2003/en/87309
[11] Regolamento UE 2024/1351 del 14 maggio 2024